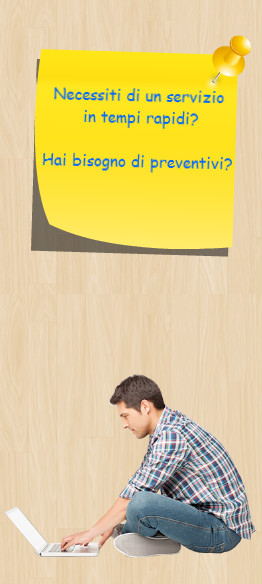Caratteristiche della liquidazione coatta amministrativa: in cosa consiste e quando vi si ricorre
04 Febbraio 2025 - Redazione



Il fallimento è una procedura concorsuale che ha lo scopo di tutelare i creditori di un’impresa insolvente, attraverso la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore.
In altre parole, quando un’impresa non è più in grado di onorare i propri debiti, il sistema legale prevede una serie di azioni per distribuire i beni dell’impresa ai creditori, cercando di liquidare il debito in modo equo.
In questa guida approfondiremo le principali caratteristiche del fallimento, le tipologie di soggetti che possono essere coinvolti, le procedure correlate come la liquidazione coatta amministrativa e il concordato fallimentare, e le differenze con altre forme di insolvenza.
- Indice contenuti
- Cos'è un fallimento e come funziona?
- Chi può essere soggetto alla procedura di fallimento?
- Cos'è la liquidazione coatta amministrativa?
- Cos'è il concordato fallimentare e come funziona?
- Innovazioni nel concordato fallimentare: Nuove possibilità e cambiamenti
- Impatti del fallimento e soluzioni alternative
Il fallimento è una procedura legale che viene avviata quando un'impresa si trova in stato di insolvenza, cioè non è più in grado di far fronte ai propri impegni finanziari.
La procedura fallimentare si attiva su richiesta dell'imprenditore, dei creditori o dell'autorità giudiziaria, ed è finalizzata alla liquidazione del patrimonio dell’impresa insolvente per soddisfare, almeno parzialmente, i creditori.
Una volta che il tribunale dichiara il fallimento, il patrimonio dell’impresa viene liquidato, cioè venduto, e i proventi sono distribuiti tra i creditori in modo proporzionale all’importo dei loro crediti.
Il fallimento può riguardare singoli imprenditori o società di persone e capitali, ma ci sono alcune eccezioni nella normativa che vedremo più avanti.
Chi può essere soggetto alla procedura di fallimento?Non tutti i soggetti possono essere soggetti alla procedura di fallimento. Sono principalmente interessati dal fallimento gli imprenditori individuali e le società di persone e di capitali che esercitano un'attività economica in ambito commerciale.
La legge fallimentare esclude invece alcune categorie di soggetti, tra cui:
- Enti pubblici, che non possono dichiarare fallimento, ma possono trovarsi in altre tipologie di crisi finanziaria (es. dissesto finanziario).
- Piccoli imprenditori che non raggiungono una soglia minima di ricavi, patrimonio o debiti, e che sono quindi esentati da questa procedura.
- Altri soggetti che godono di deroghe alla normativa generale, come le microimprese o le attività non commerciali.
Nel caso delle società di capitali, come le S.p.A. o le S.r.l., la dichiarazione di fallimento riguarda specificamente le situazioni in cui l'impresa non ha più risorse sufficienti per coprire i debiti, e dove non esistono soluzioni alternative come la ristrutturazione aziendale o la ristrutturazione del debito.
Cos'è la liquidazione coatta amministrativa?
Un'alternativa al fallimento è la liquidazione coatta amministrativa, che si applica principalmente alle grandi imprese o a quelle che operano in settori particolari, come il settore bancario, assicurativo o le società cooperative.
La liquidazione coatta amministrativa è avviata quando si riscontrano gravi irregolarità gestionali che compromettono la continuità aziendale, o in caso di insolvenza grave.
A differenza del fallimento, questa procedura è gestita da un commissario liquidatore nominato dalle autorità amministrative, che agisce sotto la supervisione di un comitato di sorveglianza, composto da esperti nel settore dell’attività in difficoltà.
Come funziona la liquidazione coatta amministrativa?
Il processo di liquidazione coatta amministrativa prevede una serie di fasi, a partire dalla nomina del commissario liquidatore, che si occupa di gestire l’impresa in difficoltà e di comunicare ai creditori l'importo dei debiti che vantano.
Successivamente, si avvia una fase interlocutoria durante la quale i creditori possono presentare osservazioni o istanze.
Una volta completata questa fase, il commissario redige l’elenco definitivo dei creditori ammessi e di quelli respinti, in base alle evidenze e alle prove fornite.
La fase liquidatoria successiva consiste nella vendita dei beni mobili e immobili dell’impresa, e il ricavato viene distribuito tra i creditori.
In caso di fallimento bancario o fallimento in altri settori regolati da specifiche normative, l'operazione è accompagnata da un piano di recupero che può includere la cessione di attività o la ristrutturazione delle passività aziendali.
Cos'è il concordato fallimentare e come funziona?Il concordato fallimentare è un'alternativa alla liquidazione fallimentare. In sostanza, si tratta di un accordo tra l’imprenditore in difficoltà e uno o più creditori per ristrutturare il debito e risolvere la crisi finanziaria senza arrivare alla liquidazione totale dell’impresa.
In pratica, l’imprenditore, attraverso un terzo soggetto (come un consulente finanziario o un altro creditore), presenta una proposta che permette di soddisfare i creditori in misura maggiore rispetto alla liquidazione fallimentare.
Differenze tra liquidazione fallimentare e concordato
Il concordato fallimentare offre numerosi vantaggi rispetto alla liquidazione fallimentare, tra cui:
- Migliore recupero per i creditori: Il concordato prevede che i creditori ricevano una percentuale maggiore dei debiti rispetto a quanto otterrebbero con la vendita forzata dei beni aziendali.
- Maggior tempo per ristrutturare: Il concordato consente un periodo di ristrutturazione aziendale e finanziaria, durante il quale l’impresa può continuare a operare, a differenza della liquidazione che implica la cessazione dell'attività.
- Maggiore flessibilità: La proposta di concordato può includere varie soluzioni, come il pagamento in rate, la cessione di beni aziendali, o l’emissione di nuovi titoli di debito.
Un’importante novità rispetto alla legge fallimentare del 1942 riguarda chi può presentare la proposta di concordato.
In passato, solo l’imprenditore fallito aveva la possibilità di proporre un concordato, mentre oggi la proposta può essere presentata anche da creditori o terzi (ad esempio, soggetti che intendano assumere un controllo parziale o totale dell’impresa).
Inoltre, non è più necessario attendere che lo stato passivo sia reso esecutivo per presentare la proposta di concordato: è sufficiente che venga redatto un elenco provvisorio dei creditori attraverso la contabilità aziendale o altre fonti di informazione.
La legge prevede che il concordato possa essere presentato anche se il fallito non ha ancora ricevuto una dichiarazione formale dello stato passivo, ma solo dopo un anno dalla dichiarazione di fallimento o entro due anni dal decreto di esecutività.
Impatti del fallimento e soluzioni alternativeMentre il fallimento può essere un’esperienza difficile per l’imprenditore, esistono alternative e soluzioni che permettono di limitare i danni e, talvolta, recuperare la stabilità economica.
Le procedure come il concordato fallimentare e la liquidazione coatta amministrativa offrono strumenti di risoluzione della crisi che consentono una gestione più controllata delle difficoltà aziendali, tutelando anche i diritti dei creditori.
Un altro aspetto fondamentale da considerare è che la ristrutturazione del debito è una soluzione che molte imprese in difficoltà adottano per evitare il fallimento completo.
In questi casi, l’imprenditore può negoziare con i creditori per ottenere una moratoria sui debiti, ristrutturare i pagamenti o ottenere condizioni più favorevoli.